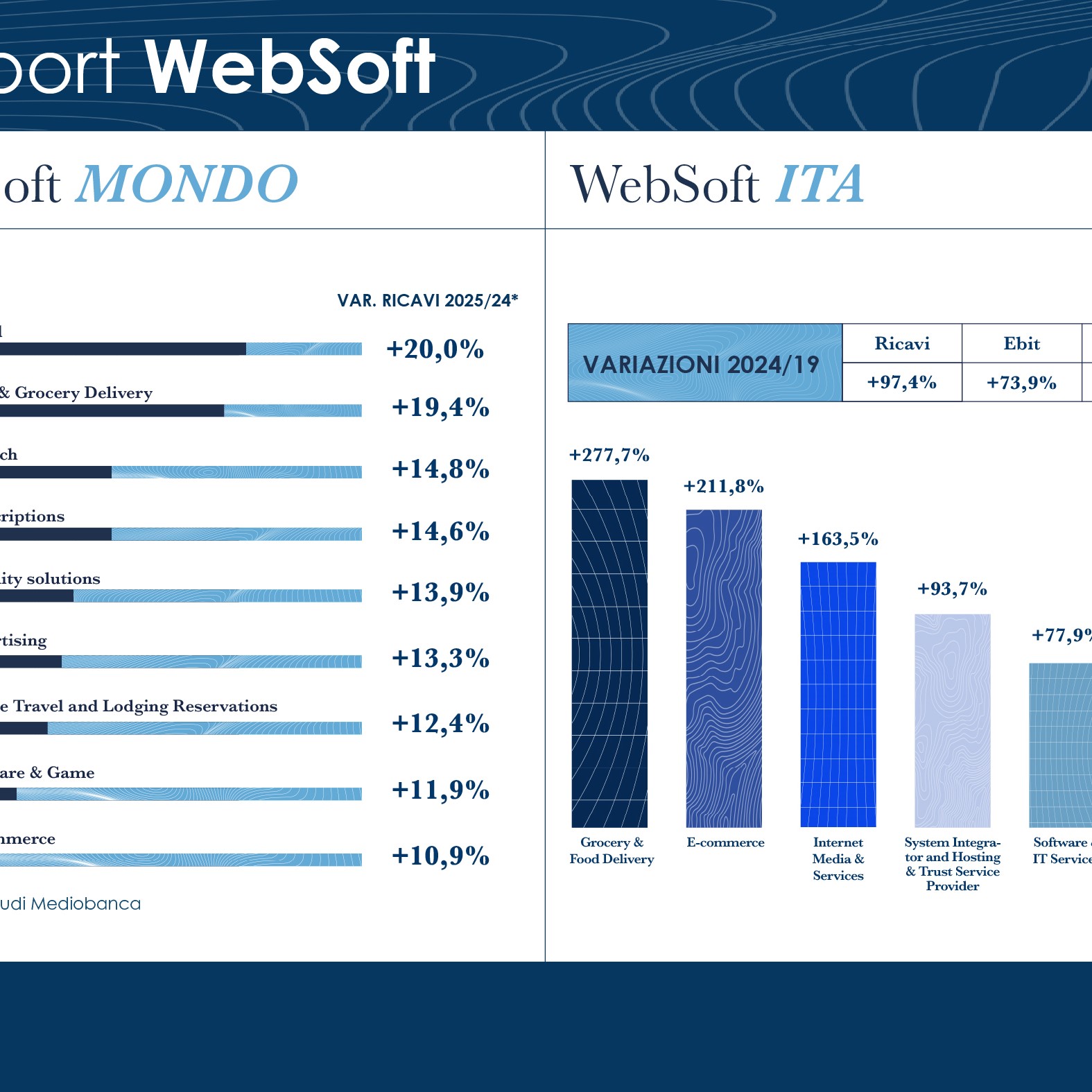Non una bocciatura, ma una richiesta di minore rigidità. Si chiude davanti alla quinta sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea il rinvio pregiudiziale, proposto dal Tribunale di Roma, per risolvere un dubbio interpretativo riguardante la direttiva 2014/26/26/UE (cd. “Direttiva Barnier” sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi). Infatti, il 21 marzo scorso, pronunciandosi nella causa C-10/22, la Corte europea ha emanato il proprio giudizio affermando che la soluzione data dal legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva – ossia riservare in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori nonché agli altri organismi di gestione collettiva l’intermediazione dei diritti d’autore, giustificabile in linea di principio – non è “proporzionata” e lede quindi il principio di libera prestazione dei servizi. Sebbene la sentenza sia stata già ampiamente commentata come “bocciatura” del sistema italiano di disciplina delle collecting, il testo merita un approfondimento per individuare i passaggi che dovranno ora essere seguiti dal legislatore italiano.
La vicenda giudiziale è iniziata in modo peculiare, in quanto la causa generatrice vedeva contrapposti due soggetti le cui posizioni difensive erano sostanzialmente identiche. Da una parte la LEA, che ha chiesto al Tribunale di Roma che fosse ordinato alla Jamendo (società di diritto lussemburghese, entità di gestione indipendente dei diritti d’autore che svolge la sua attività in Italia) di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d’autore in Italia. Dall’altra la stessa Jamendo, che sosteneva la tesi di un’errata trasposizione della direttiva 2014/26 nel diritto italiano, affermando che il legislatore nazionale avrebbe dovuto conferire alle entità di gestione indipendenti i diritti previsti dalla direttiva Barnier.
Il Giudice romano ha ritenuto pertanto di rinviare la questione alla CGUE, sul seguente quesito: “Se la direttiva [2014/26] debba essere interpretata nel senso che essa osti ad una legge nazionale che riservi l’accesso al mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore, o comunque la concessione di licenze agli utilizzatori, solo ai soggetti qualificabili, secondo la definizione della medesima direttiva, come organismi di gestione collettiva, escludendo quelli qualificabili come entità di gestione indipendenti, costituiti sia nel medesimo Stato sia in altri Stati membri”
La singolare situazione processuale ha fatto eccepire al Governo italiano che l’identità delle posizioni sostenute dalle parti (volte, in sostanza, a far dichiarare l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa italiana) era sufficiente a dimostrare il carattere artificioso del procedimento principale. Tale eccezione, parzialmente accolta, ha sortito l’effetto di limitare fortemente l’ambito di rilevanza della sentenza, in quanto la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui riguarda le entità di gestione indipendenti stabilite in Italia, rilevando che la Jamendo è stabilita in Lussemburgo, e l’estensione della questione pregiudiziale anche alle entità di gestione indipendente italiane “ha carattere ipotetico”.
Fatta questa necessaria premessa, va detto che la sentenza della CGUE è tutt’altro che una censura tout court del sistema italiano, come troppo frettolosamente è stata interpretata: i Giudici europei hanno compiuto una disamina approfondita della direttiva, descrivendo le differenze tra organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente, concludendo che “il trattamento differenziato, operato dalla normativa nazionale di cui trattasi, delle entità di gestione indipendenti rispetto agli organismi di gestione collettiva risponda all’intento di conseguire l’obiettivo di protezione del diritto d’autore in modo coerente e sistematico, dal momento che la direttiva UE 2014/26 assoggetta le entità di gestione indipendenti ad obblighi meno rigorosi rispetto a quelli degli organismi di gestione collettiva per quanto riguarda, in particolare, l’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la concessione delle licenze, le modalità di governance nonché il quadro di sorveglianza cui sono soggette. In dette circostanze, tale trattamento differenziato può essere considerato idoneo a garantire il conseguimento di detto obiettivo”.
Insomma, organismi ed entità di gestione non sono affatto uguali, in quanto gli organismi sono soggetti ad obblighi molto più restrittivi, e la riserva dell’attività di intermediazione appare astrattamente giustificata. Ha errato però il legislatore italiano nel precludere, in modo assoluto, a qualsiasi entità di gestione indipendente, l’attività in questione, senza prevedere la possibilità di imporre preventivamente determinati obblighi. In proposito non manca nella pronuncia un suggerimento specifico: “una misura meno lesiva della libera prestazione di servizi potrebbe consistere, segnatamente, nel subordinare la prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d’autore nello Stato membro interessato a obblighi normativi specifici che sarebbero giustificati riguardo all’obiettivo di protezione del diritto d’autore”.
In conclusione, secondo la CGUE “l’articolo 56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva UE 2014/26, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri”.
Si può legittimamente dubitare che si tratti di una vittoria per le entità di gestione indipendenti. Al di là del segnalato limite territoriale della statuizione – che, come detto, non riguarda le entità italiane – queste ultime dovranno, secondo i principi espressi dalla Corte e in base a quanto stabilirà di conseguenza il legislatore italiano, adeguarsi a criteri disciplinari molto più stringenti degli attuali. Auspicabilmente, potrebbe presentarsi l’occasione per introdurre, finalmente, criteri di certezza e trasparenza con riguardo a mandati e rappresentatività, come CRTV chiede ormai da tempo. Non resta quindi che attendere gli interventi di adeguamento, nella speranza che essi portino certezza ed equità in un settore così delicato.